Per appuntamento
La seduta può essere svolta presso il mio studio oppure online tramite videochiamata.
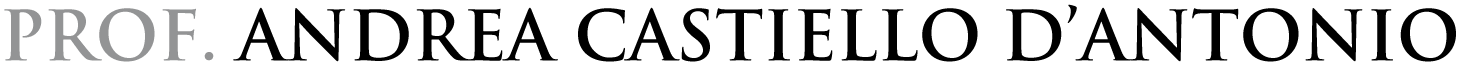
La seduta può essere svolta presso il mio studio oppure online tramite videochiamata.
Immagini che curano. La psicoanalisi visiva di Sigmund Freud
Con una certa frequenza si leggono recensioni di libri che iniziano con parole del tipo “il libro che presentiamo colma un vuoto importante…”, per poi finire con il deludere il lettore. Questo accurato e affascinante testo a firma dello storico dell’arte Horst Bredekamp merita davvero di essere introdotto con queste parole – e si deve subito aggiungere che si tratta di un lavoro originale, e per molti versi inaspettato.
Il testo è scandito in tre capitoli, un imponente apparato di note e di riferimenti, referenze iconografiche (sono molte le immagini, le foto e gli schemi riprodotti in queste pagine), la bibliografia e l’indice dei nomi. I grandi temi che sono affrontati dall’autore sono introdotti dalla Prefazione all’edizione italiana del filosofo Federico Vercellone (che insegna Estetica presso l’Università di Torino) e prendono avvio con l’analisi del freudiano Il Mosè di Michelangelo (1914).
“Nella sua analisi della novella di Jensen apparsa nel maggio del 1907, Il delirio e i sogni nella ‘Gradiva’ di W. Jensen, Freud rileva analogie strutturali tra l’archeologia e la psicoanalisi che avrebbe poi ripreso più di trent’anni dopo” (p. 86).
Freud, Roma, e il Mosè di Michelangelo, custodito in San Pietro in Vincoli (consiglio chiunque viva a Roma, o sia di passaggio, di recarsi a vedere l’imponente statua!) a cui si accede salendo una scalinata, come a voler introdurre il visitatore all’esperienza suprema.
Bredekamp indaga le relazioni di Freud con il collezionismo, con le immagini, con il viaggio – al singolare: un termine che potremmo usare per indicare che i sei viaggi compiuti da Freud verso Roma (tra il 1901 e il 1913) possono essere intesi proprio come un unico andare!
Roma come meta finale, decisiva, ma anche come sfida e grande difficoltà, come specchio di sé e nutrimento per la propria autoanalisi. Freud riferisce della profonda impressione suscitata in lui dal primo incontro con il Mosè michelangiolesco e Bredekamp ripercorre tutte le tappe dell’ideazione dell’opera (infine pubblicata nella rivista Imago nel 1914), collegandola ai processi di identificazione, alla crisi con Carl Gustav Jung, al confronto con i suoi maggiori allievi e colleghi (Abraham, Rank, Sachs, Jones), alle incertezze circa la pubblicazione fino all’ammissione di paternità, avvenuta nel 1924 (dieci anni dopo!) con la pubblicazione del decimo volume dei Gesammelte Schriften.
Le tesi esposte dall’autore sono diverse e scavano, per così dire, nel mondo delle immagini, ruotando intorno al medium costituito dalle collezioni freudiane di reperti archeologici, perlopiù sculture (stimate tra le duemila e le tremila!) ricche di pezzi greci, romani ed egizi – una dimensione sempre occultata da Freud, probabilmente perché svelarla avrebbe significato avvicinare la sua figura a quella di Jung. La collezione come un medium che si pone nelle relazioni tra analista e paziente, una presenza tacita eppur parlante, emergente, impossibile da non considerare.
Più precisamente Bredekamp afferma che “Freud coincideva con la propria collezione, e la collezione, senza di lui, era morta. Essa era il suo secondo Io” (p. 119).
“La collezione era un suo prodotto” (p. 75) legato ai molti viaggi, reali e immaginari, un prodotto dal quale soffriva a separarsi, tanto è vero che portava con sé nei luoghi di vacanza una nutrita selezione degli oggetti. E non è da trascurare l’effetto che entrare nelle stanze dello studio di Freud poteva suscitare nei pazienti anche per la presenza di un’altra entità, per così dire: “la sorpresa di imbattersi in una cagnolina equivaleva allo stupore suscitato dalla collezione. Freud ha scientemente occultato entrambe, nei propri scritti, per un motivo ben preciso: solo così poteva mantenerne intatto l’effetto” (p. 134). Si trattava della Chow chow Jofi, donata a Freud da Marie Bonaparte la quale, non a caso, dedicò un libriccino al suo Chow chow di nome Topsy, pubblicato nel 1937 – un libro che Freud, insieme alla figlia Anna, vollero tradurre in tedesco (Bonaparte M., Topsy: le ragioni di un amore Tr. it.: Bollati Boringhieri, Torino 1990).
Il terzo, importante, elemento del setting freudiano era rappresentato dai sigari.
Una passione-compulsione che non ha mai abbandonato Freud nel corso della vita e che, com’è noto, lo ha condotto infine alla morte dopo aver subìto un numero incredibile di interventi chirurgici. “Il parlare in stato di concentrazione era per lui sempre legato a una dimensione tattile e visiva” (p. 99) cosa che si esprimeva non solo nel prendere in mano un pezzo della collezione quando prendeva la parola, ma anche nel tenere tra le dita l’immancabile sigaro.
Certamente, pensando oggi a come Freud lavorava con i suoi pazienti – altra dimensione emersa lentamente nella storia della psicoanalisi per merito di investigatori come Paul Roazen – tra centinaia di reperti archeologici, Jofi (pressoché sempre presente alle sedute) e i sigari, viene da chiedersi come e dove sia nata l’idea dello studio psicoanalitico asettico e anonimo, intendendo qui proprio l’aspetto logistico e di arredamento, ma anche di comportamento dell’analista: per ricordare un solo aneddoto, è risaputo che Freud, a volte, si alzava dalla poltrona e andava a prendere uno dei suoi sigari per festeggiare una importante scoperta avvenuta con il paziente in terapia!
Curiosamente l’autore non cita i lavori di Paul Roazen (v. il suo Freud al lavoro: i suoi pazienti raccontano. 1995. Tr. it. Erre Emme, Roma, 1999) il quale ha indagato ampiamente sul Freud reale e umano (potremmo dire), né offre un panorama completo dei numerosi resoconti di pazienti ed allievi pubblicati fino ad oggi, citando invece opportunamente le maggiori biografie freudiane, da Ernest Jones, a Peter Gay fino alla più recente (magnifica) di Peter-André Alt.
Rimane da constatare che questo libro si colloca nell’intersezione tra storiografia della psicoanalisi, storia dell’arte, archeologia, iconografia, simbolismo, terapia e autoanalisi: una collocazione senza dubbio molto originale. In sostanza, questo bel lavoro di Horst Bredekamp, che si avvale della recente scoperta dei taccuini freudiani, indica che la psicoanalisi non è nata soltanto come terapia della parola, bensì come psicoterapia – o ambiente terapeutico forse sarebbe meglio dire – in cui le immagini fin dall’inizio hanno giocato un ruolo rilevante.
Di Horst Bredekamp, professore di Storia dell’arte presso la Humboldt-Universität (Berlino), ricordiamo Immagini che ci guardano e Berlino città mediterranea, tradotti entrambi da Raffaello Cortina rispettivamente nel 2015 e nel 2019.
Andrea Castiello d’Antonio
Questa recensione è stata pubblicata il 24 Agosto 2025 nel sito
PSYCHIATRY ON LINE – ITALIA